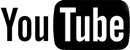Testo di Costanzo Costantini
Igor Mitoraj ha riproposto in maniera decisiva, perentoria, abbagliante, l’enigma della Bellezza, del quale parla Dostoevskij nell’ Idiota.
“Sembra che il mondo di Mitoraj - ha scritto Giovanni Testori in La resurrezione della Bellezza - esista solo per annunciarci come bellezza e armonia avranno, pur sempre, vittoria, e vittoria su tutti e su tutto... E proprio là, nei punti in cui l’antichissima legge o ordinanza ha mutilato le sue sculture, che più preme l’istanza della perfezione e più si costruisce, di bel nuovo, la legge della beltà e dell’armonia… Perché non dire che in Mitoraj non si tratta, in nessun modo, di ‘citazione’ dal passato, ma della sua emozionata e fulgida resurrezione nell’oggi? E perché non aggiungere che tutto questo avviene per insegnarci che, pur in questo nostro superbo, ricco, ma idiota e sconciato presente, armonia e bellezza sono possibili e realizzabili ancora, e ancora in tutta la loro gloria?».
“In Mitoraj -ha scritto a sua volta Antonio Paolucci - a me ha colpito la sacralità dell’immagine, l’idea della Bellezza eterna e misteriosa che forse -anzi certamente- è l’ombra di Dio sulla Terra”.
È, questa, l’idea agostiniana secondo cui la bellezza terrena è un riflesso della Bellezza di Dio, “Padre della Bellezza, Bellezza di ogni Bellezza”.
Aveva detto il doganiere Rousseau a Brancusi: “Ho capito ciò che vuoi fare: vuoi trasformare l’antico in moderno”. È quello che ha fatto e che fa, in modo del tutto originale, lo scultore polacco. Mitoraj ha posto termine al conflitto fra antico e moderno: nella sua opera l’antico e il moderno si compenetrano in una sintesi superba, inquietante, indecifrabile. Le sue sculture frammentarie, mutilate, infrante, ferite, bendate hanno ben poco a che fare con il contrasto michelangiolesco di finito e “non finito”. Come ha osservato Maurizio Calvesi, “questo contrasto in Michelangelo non era altro che il drammatico affiorare della materia allo stato grezza in alcune parti della scultura, mentre altre erano compiutamente modellate”.
Mitoraj modella compiutamente le sue sculture infrante, scisse, mutilato, modella compiutamente ogni frammento scultoreo - una mano, un piede, un occhio, una bocca, un sesso, un’ala, un torso -, ma questa frammentazione rispecchia la condizione umana e sociale odierna: l’”io diviso”, la scissione della personalità, la violenza che l’uomo esercita contro l’uomo e contro se stesso, i conflitti profondi della coscienza e della subcoscienza, l’allarmante pulsione autodistruttiva che serpeggia nel mondo in cui viviamo. Egli dimostra che la bellezza sopravvive ad ogni mutilazione, ad ogni ferita, ad ogni possibile scempio, come sopravvive la bellezza dei petali d’un fiore che venga reciso e
infranto. Se è vero che il tempo è una nostra percezione soggettiva, come insegnano filosofi e scienziati, le sculture di Mitoraj riflettono in pieno il nostro tempo: un, tempo frantumato, come è frantumato l’uomo, un tempo “impazzito”, in cui il passato invade il futuro e il futuro invade il passato, investendo e frantumando anche il presente. Riflettono il lavorio che compie il tempo. Fanno pensare alle statue di cui parla la Yourcenar in Il Tempo, grande scultore: “Statue spezzate così bene che dal rudere nasce un’opera nuova, perfetta nella sua stessa segmentazione: un piede nudo che non si dimentica, poggiato su una lastra, una mano purissima, un ginocchio piegato in cui si raccoglie tutta la velocità della corsa, un torso che nessun volto ci impedisce di amare, un seno o un sesso di cui riconosciamo più che mai la forma del fiore o del frutto, un profilo ove la bellezza sopravvive in un’assenza assoluta di aneddoto umano o divino, un busto dai tratti corrosi, sospeso a mezzo fra il ritratto e il teschio” ( Il Tempo, grande scultore, Einaudi Tascabili, 1985 e 1994).
Mitoraj ha rinnovato il linguaggio artistico, che si dibatteva in una senza precedenti. Gli avanguardisti dei primi decenni del secolo avevano esaurito la loro carica sovversiva e non restavano sul campo che i loro innumerevoli epigoni, ripetitori ad oltranza del picassismo e del duchampismo.
Mitoraj ha fatto irruzione in questo panorama con un’ immaginazione linguistica nuova, imprimendo alla scultura una svolta, un’impronta inedita, “antica” e nello stesso tempo più che moderna.
Ne è una riprova la mostra che gli fu dedicata nel 1999 a Firenze, fra Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli e il Museo Archeologico: una superba costellazione di sculture giganti, frammenti indecifrabili, teste tagliate o addormentate, visi bendati, occhi dalle orbite vuote, Ikari lesionati o implosi come per effetto di sismi endogeni, torsi lacerati, chiodati, corazzati, bocche ambigue, Eros inquietanti o perturbanti, in una gamma di marmi bianchi splendenti o bronzi dalle patine preziose, che rilucevano fra il verde degli alberi, fino alla Nascita di Eros, al colossale Ikaro e alla imponente Ikaria, i bronzi policromi che sovrastavano, dalla cima del bosco, l’intero paesaggio.
Il Giardino mediceo non aveva nulla da invidiate al Forte del Belvedere, sul quale avevano esposto Wotruba, Henry Moore e altri scultori contemporanei. Se dal Forte si poteva ammirare la cupola di Santa Maria Novella, dal Giardino si ammirava la cupola dì Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto e la cupola della Chiesa di Santo Spirito. Nel Museo Archeologico, nel quale non avevano mai avuto accesso artisti moderni, le opere di Mitoraj si distinguevano dalle statue antiche, dai frammenti e reperti del passato, per la novità delle materie, l’invenzione stilistica, i tagli inflitti alle figure, l’originale tonalità delle patine.
Della scultura di Mitoraj si. può dire ciò che diceva Jean Genet della scultura dì Giacometti: “Ogni opera d’arte che vuole attingere i livelli più alti deve, con pazienza e applicazione infinite, ripercorrere fin dall‘attimo del concepimento i millenni, raggiungere, se possibile, la notte immemorabile popolata di quei morti. che si riconoscono in essa. L’opera d’arte comunica la solitudine di ogni essere e di ogni cosa, solitudine che è la nostra gloria più certa, che vuol dire segreta regalità, profonda incomunicabilità, senso più o meno oscuro di un’invincibile singolarità”.
Nella società di massa, nell’epoca dei falsi divi di massa, Igor Mitoraj si ripropone come l’artista solitario, che opera in solitudine, al di fuori di ogni corrente, con un’energia che ha del prodigioso.
L’artista polacco reincarna il Singolo kierkegaardiano.
Anche per lui, se non specialmente per lui, non vi è per la Bellezza altra origine, come dice ancora Jean Genet, che la ferita, singola, diversa per ognuno, visibile o celata, che ogni uomo preserva in sé e in cui si ritrae quando vuole lasciare il mondo per una solitudine temporanea, ma profonda. Come quella di Giacometti, la scultura di Mitoraj rivela la ferita segreta di ogni essere e di ogni cosa, perché li illumini.
Nelle opere di Mitoraj la Bellezza è come venata da una sottile malinconia, una malinconia sottesa segretamente, come una lama, alle forme e alle patine, ai pieni e ai vuoti, ma che lo spettatore sensibile non manca di percepire. Come è più che noto, della malinconia si era occupato già Aristotile, a proposito degli, uomini di genio o delle personalità d’eccezione, quali Empedocle, Platone, Socrate, Il filosofo greco l’attribuiva a un eccesso di fluidi atrabiliairi e di altri umori della fisiologia ippocratica. È tuttavia da lui, attraverso il Ficino, che arriva a Dürer, l’autore della celeberrima Melencholia I. La melencholia o quel furor rnelancholicus al quale andavano soggetti lo stesso Dürer, il Pontormo, Michelangelo, Leonardo, il Borromini. e molti artisti moderni.
Scrive Maurizio Calvesi in La melanconia di Albrecht Dürer: “Il Ficino riprendeva invece una tesi di Aristotile secondo cui i melanconici, in virtù della loro stessa fragilità nervosa, finiscono spesso per eccellere. E così tutti coloro che si distinguono in filosofia, in politica, in poesia o nelle arti, sono melanconici: alcuni di essi al punto che soffrono per malesseri prodotti dalla bile nera”. Egli cita il Panofsky che dice: “I neoplatonici fiorentini avvertirono presto che questa dottrina aristotelica forniva una base scientifica alla teoria platonica del furore divino…. L’espressione furor melancholicus divenne sinonimo di furor divinus. Quella che era stata una calamità e, nella sua forma più attenuata, uno svantaggio, divenne un privilegio ancora pericoloso ma tanto più esaltato: il privilegio del genio” (Einaudi, 1993).
Ma la malinconia che traluce nelle opere di Mitoraj ha un segno particolare: è una malinconia profonda, che trae motivo dalle vicende personali dello scultore, una malinconia esistenziale, che nasce dall’inquietudine, dall’angoscia, dall’ossessione, ma nello stesso tempo si tramuta in una malinconia artistica, stilistica, si potrebbe dire. La malinconia come stile. “La mia allegrezza è la malinconia”, diceva Michelangelo, con un ossimoro geniale.
Mitoraj preannuncia, attraverso i suoi eroi “dormienti”, quel risveglio dei poeti di cui parlava Hoerderlin, quel secolo dei “titani” profetizzato da Ernst Junger.
È un “titano” nel tempo e fuori del tempo, nella storia e al di là della storia: nel tempo tragico in cui gli è capitato di vivere, nella storia martoriata d’Europa e specialmente della Polonia.
Mitoraj rende credibile la profezia enunciata da Dostoevskij nell’ Idiota:
“Signori - gridò a tutti l’ateo Ippolit -, il principe Myskin afferma che la Bellezza salverà il mondo”.
Che la Bellezza possa salvare il mondo, è un’idea ripresa più volte, negli ultimi tempi, anche dall’ex Arcivescovo di Milano, cardinale Martini. Nella sua Lettera Pastorale del 9 settembre 1999, l’illustre presule citava il summenzionato brano dell’ Idiota, dopodiché commentava: “Quale bellezza salverà il mondo? Il principe Myskin non risponde alla domanda (come un giorno il Nazareno davanti a Pilato non aveva risposto che con la Sua presenza alla domanda: ‘Che cos’è la verità?’). Sembrerebbe quasi che il silenzio di Myskin - che sta accanto con infinita compassione d’amore al giovane che muore di tisi a diciotto anni - voglia dire che la bellezza che salva il mondo è l’amore che condivide il dolore. La bellezza è la metafora che meglio richiama ciò che suscita attrazione, sorpresa, dedizione, innamoramento, entusiasmo; ciò che l’amore scopre nella persona amata, quella persona che si intuisce come degna del dono di sé. La bellezza che rimanda alla Trinità non è quella dei corpi abbronzati, ma quella di fronte a cui, come candidamente diceva Kant, ‘l’animo avverte una certa nobile elevazione al di sopra della semplice predisposizione al piacere sensibile’. Poiché la bellezza ha questo valore metaforico, con ‘bellezza’ si può intendere il termine biblico ‘gloria’, quando è riferito a Dio. Essere testimoni della Bellezza che salva nasce dal farne continua, e sempre nuova esperienza: ce lo fa capire lo stesso Gesù quando, nei Vangelo di Giovanni, sì presenta come il ‘pastore bello’: ‘Io sono il pastore bello. Il bel pastore offre la vita per le sue pecore’ “. Correggendo vagamente Platone, che identificava il bello con il bene, il porporato anteponeva la bellezza alla bontà, che ne è importante fall-out ma che -sola- non attrae al mistero, non ne comunica il sapore: “Se la bellezza che salva il mondo. è l’amore capace di condividere il dolore, bello è il Dio cristiano trinitario che, avendo in Gesù esperienza della morte, non dà una risposta teorica alla domanda sul perché dei dolore del mondo, ma si offre come la ‘custodia’, il ‘grembo’ di questo dolore; il Dio che non lascia andare perduta nessuna lacrima dei suoi figli perché le fa sue”.
In un’intervista concessa al settimanale l’Espresso nello stesso 1999, il cardinal Martini si rifaceva, oltre che all’ Idiota, anche al Diario di uno scrittore, nel quale Dostoevskij dice che “Cristo è l’ideale della bellezza umana”, e affrontava più esplicitamente il tema della bellezza salvifica. Alla domanda: “C’è una bellezza che salva anche per i non credenti?”, rispose: “Certamente bisogna guardare le cose con gli occhi della fede per parlare come Pietro sul monte Tabor: ‘È bello per noi stare qui’. Tuttavia alcune vestigia della bellezza dì Dio si trovano sparse dappertutto. Anche un non credente, purché sia ‘pensante’ e si ponga domande serie sul senso della vita, può percepire delle bellezze che non sono semplicemente seducenti. Penso alla forma di quasi estasi che può produrre l’ascolto della musica, penso alle bellezze della poesia, penso allo splendore delle arti figurative, penso al fascino di molti gesti di solidarietà. Anche il non credente scorge in queste realtà qualcosa che lo affascina e lo conquista e che va al di là di quello che è il calcolo e il grigiore della vita di ogni giorno. E così possibile cogliere qualche riflesso del mistero della bellezza di Dio”. E alla domanda: “Quali sono nella liturgia cattolica i momenti in cui ‘la bellezza che salva’ viene espressa con più forza che evidenza”, rispose: “la bellezza che salva è la rivelazione della Trinità, che viene fatta in particolare in Gesù Cristo e nella sua morte e resurrezione. A questo fa riferimento la Trasfigurazione di Raffaello. Nel quadro, accanto alla scena della trasfigurazione, c’è la scena della guarigione di un ragazzo lunatico. Il pittore ha così congiunto l’esperienza della bellezza di Cristo con la forza salvatrice del miracolo. Nella liturgia cattolica il momento in cui questa bellezza viene espressa con più forza è certamente la celebrazione della Pasqua e dell’intero Triduo pasquale. Quando queste cerimonie sono vissute con verità e profondità, coinvolgono profondamente il credente e lo immergono nella bellezza del mistero dì Dio”.
Dal canto suo Giovanni Paolo Il, nella sua Lettera agli Artisti dello stesso 1999, riprendeva l’idea dostoevkijana della bellezza come enigma, come mistero. Egli scriveva: “ln quanto ricerca del bello, frutto di un’immaginazione che va al, di là del quotidiano, l’arte è per sua natura un appello al Mistero. Persino quando scruta le profondità più oscure dell‘anima, o gli aspetti più sconvolgenti del male, l’artista si fa in qualche modo voce dell‘universale attesa di redenzione. Si comprende, dunque, perché al dialogo con gli artisti la Chiesa tenga in modo speciale e desideri che nella nostra età si realizzi una nuova alleanza con gli artisti, come auspicava il mio venerato predecessore Paolo VI. Da tale collaborazione la Chiesa si augura una rinnovata ‘epifania’ di bellezza per il nostro tempo”.
E nel discorso pronunciato in occasione dei restauri conclusivi della Cappella Sistina, Giovanni Paolo Il affermava: “Il mio auspicio è che, nel solco di quanto è testimoniato in questo ‘santuario’ unico al mondo, si ristabilisca nel nostro tempo la feconda alleanza di fede e arte, perché il ‘bello’, epifania della bellezza suprema di Dio, possa illuminare l’orizzonte del Millennio che sta per iniziare
Ha scritto ancora Giovanni Testori: “Della sua patria, infinite volte offesa, occupata e calpestata, Mitoraj reca in sé, ed esibisce poi nelle sculture, le ferite e le mutilazioni. E uno scultore fuori di ogni possibile catalogazione. A vederlo, sembra l’incarnazione stessa di come abbiamo sempre pensato dovesse essere Sigismondo, il famoso ‘prigione’ protagonista de La vita è sogno, tragedia che, vedi caso, Caldéron de la Barca ha voluto ambientare in Polonia. Tuttavia vi è qualcosa di molto più profondo che lega il sontuoso, dotatissimo drammaturgo del ‘siglo de oro’ all’innamorato scultore di questi busti acefali, di, queste teste ferite nella gloria o glorificate nelle ferite. Questo qualcosa è proprio lo stato di non separabilità che esiste tra realtà e sogno. Ciò che va respinto, ove mai qualche critico ne fosse tentato, è di legare la scultura di Mitoraj agli impossibili recuperi neoclassici. In Mitoraj l’impossibile diventa plasticamente possibile. In Mitoraj la classicità è un sogno, proprio in quanto il sogno è la sola realtà che egli può vivere. Tremante e sublime in ogni dettaglio, possiede, nel suo arco, una corda che lo rende nuovo, mai visto prima, e inimitabile. Lo sue teste, ora segnate da sevizie e torture, ora deposte come lo furono quelle dei martiri d’ogni tempo e d’ogni fede, i suoi busti, sotto la cui pelle qualcuno ha deposto ex voto e amuleti d’una perduta, adorante religione, mostrano che il disseppellimento della Bellezza ha scatenato e scatena in lui una sorta dì accanimento. Come se avvertisse che il nostro tempo la Bellezza non sa più veramente accoglierla ed amarla. Per quanto possa parer impossibile, Mitoraj ci avvisa che nessuna reale cognizione della Bellezza è oggi possibile senza attraversare la sua e la nostra sofferenza, la sua e la nostra mutilazione. Ma, appunto perché sofferenza e mutilazione sono riferite a un bene insopprimibile, esse assumono la grandezza e la maestà proprie solo a ciò che è veramente sacro”.
Tratto dal libro su Igor Mitoraj di Costanzo Costantini, edito dal Cigno